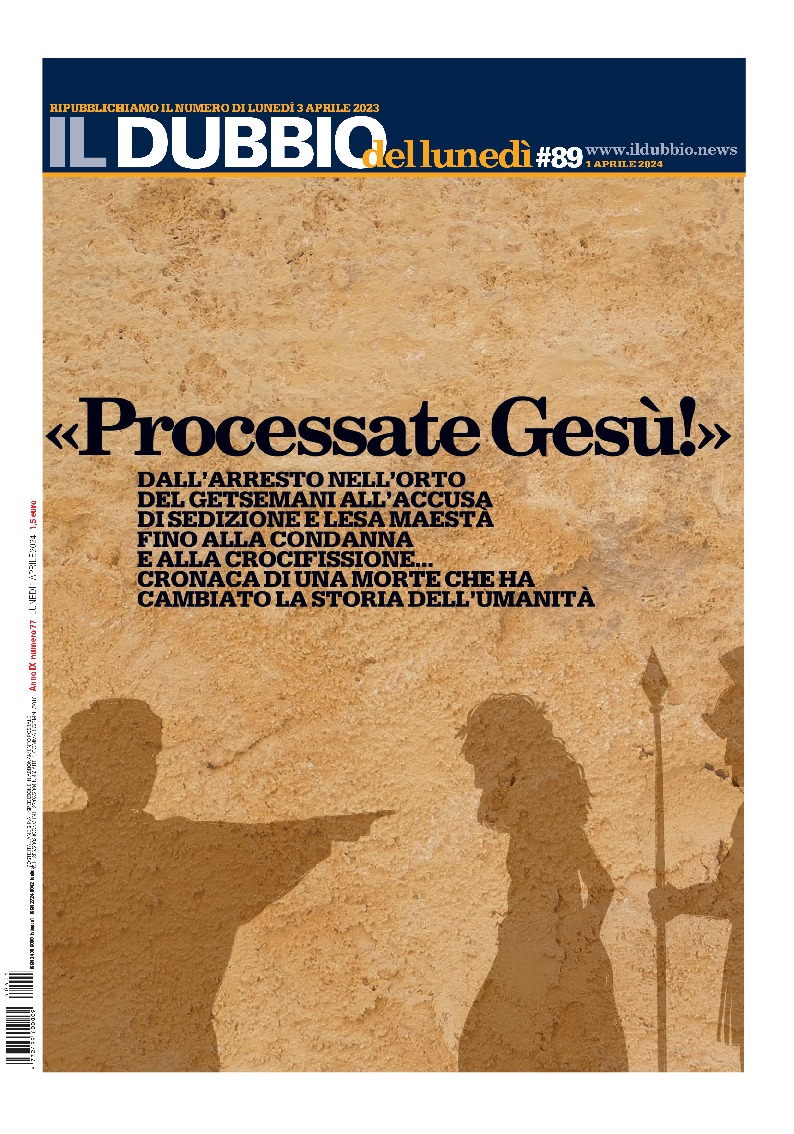PHOTO
SEBASTIANO ARDITA MAGISTRATO
Abbiamo letto sul sito del Corriere della Sera un’intervista al Procuratore Aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, sui recenti arresti disposti dall’AG di Palermo, che avrebbero evidenziato l’uso indebito di telefonini in carcere. Senza entrare nel merito dell’indagine, ci preme intervenire su alcune affermazioni del magistrato. Il dottor Ardita sostiene che «col pretesto del sovraffollamento si è deciso di aprire le celle dei mafiosi, consentendo loro di controllare i penitenziari», con un aumento di reati e suicidi. Inoltre, denuncia «circolari ministeriali e disposizioni che hanno favorito rivolte e la presenza mafiosa nelle carceri».
Ora, ci riesce difficile far finta di nulla rispetto alle sopra riportate frasi, anche perché, oltre a non essere suffragate, come troppo spesso accade, da dati certi, esse finiscono per alimentare una pericolosa disinformazione dell’opinione pubblica, indotta, così, a coltivare logiche di estrema inciviltà, condensate nelle aberranti frasi del “gettare la chiave”, del “marcire in carcere” o, come avvenuto di recente, a opera di un sottosegretario alquanto eccentrico, del “togliere il respiro ai detenuti”.
Ma vediamo i dati. Il regime delle celle aperte è stato introdotto nel 2015 solo per le sezioni di Media Sicurezza, non per quelle di Alta Sicurezza dove sono detenuti i mafiosi. Tale misura rispondeva alla condanna della Cedu (sentenza Torreggiani) per il trattamento degradante dei detenuti. Con la pandemia, nel 2020 le celle sono state chiuse per motivi sanitari. Tuttavia, il Dap, nel 2022, ha reintrodotto una gestione più rigida, riducendo il regime aperto. I dati mostrano che, nel periodo 2013- 2017, le aggressioni agli agenti erano circa 450 all’anno. Nel 2023 sono salite a 1.760, e nel 2024 hanno raggiunto le 2.154. Paradossalmente, il picco si è registrato proprio nel ritorno al regime chiuso, mentre gli studi di Antigone evidenziano che la custodia aperta ha ridotto i conflitti.
Quanto alle rivolte, il pensiero corre velocemente alla pagina più buia delle carceri italiane. Come ricorderanno i più, in concomitanza con la esplosione della pandemia da Covid 19, si sono registrati improvvise e violente rivolte negli istituti penitenziari. Nel marzo 2020, la paura del contagio e la sospensione dei colloqui scatenarono rivolte in 57 istituti, coinvolgendo 7.517 detenuti, con 13 morti: - 3 a Rieti, 1 a Bologna, 5 a Modena, - 4 trasferiti da Modena e deceduti ad Ascoli, Alessandria, Parma e Verona.
All’epoca si diffuse la narrazione che la mafia avesse orchestrato i disordini, ma l’inchiesta della Commissione Lari ha escluso questa ipotesi. Le rivolte furono il risultato del sovraffollamento, della cattiva gestione sanitaria e del senso di abbandono. Inoltre, i detenuti di Alta Sicurezza non vi parteciparono e, in alcuni casi, cercarono di far rientrare i disordini.
Veniamo, infine, ai suicidi in carcere. Affermare che l’impennata dei suicidi sia il segno di occupazione prepotente delle carceri da parte della criminalità mafiosa, a discapito dei diritti dei detenuti, appare smentita dall’analisi delle statistiche ufficiali. La rilevazione analitica fornita dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale ha segnalato come l’ 80% dei suicidi in carcere nel 2024 si sono verificati in circuiti e sezioni penitenziarie a celle chiuse o isolate, il 95% circa in istituti con elevati indici di sovraffollamento, in molti di essi non vi sono detenuti in Alta Sicurezza.
Su una cosa ci sentiamo, tuttavia, in pieno accordo con il dottor Ardita, sull’assoluta incapacità di gestione del settore penitenziario e sul fallimento delle politiche praticate negli anni da tutti i governi, a prescindere dal colore, per il carcere. Non a caso da tempo sosteniamo l’assoluta urgenza di rivedere gli assetti istituzionali del Dap, troppo spesso appannaggio di magistrati fuori ruolo, specie del pubblico ministero, per affidarne la gestione a manager di alto profilo in grado di far camminare sulle proprie gambe la più grande azienda di Stato, realizzando, così, in pieno il dettato costituzionale del reinserimento sociale, anche produttivo, dei detenuti.