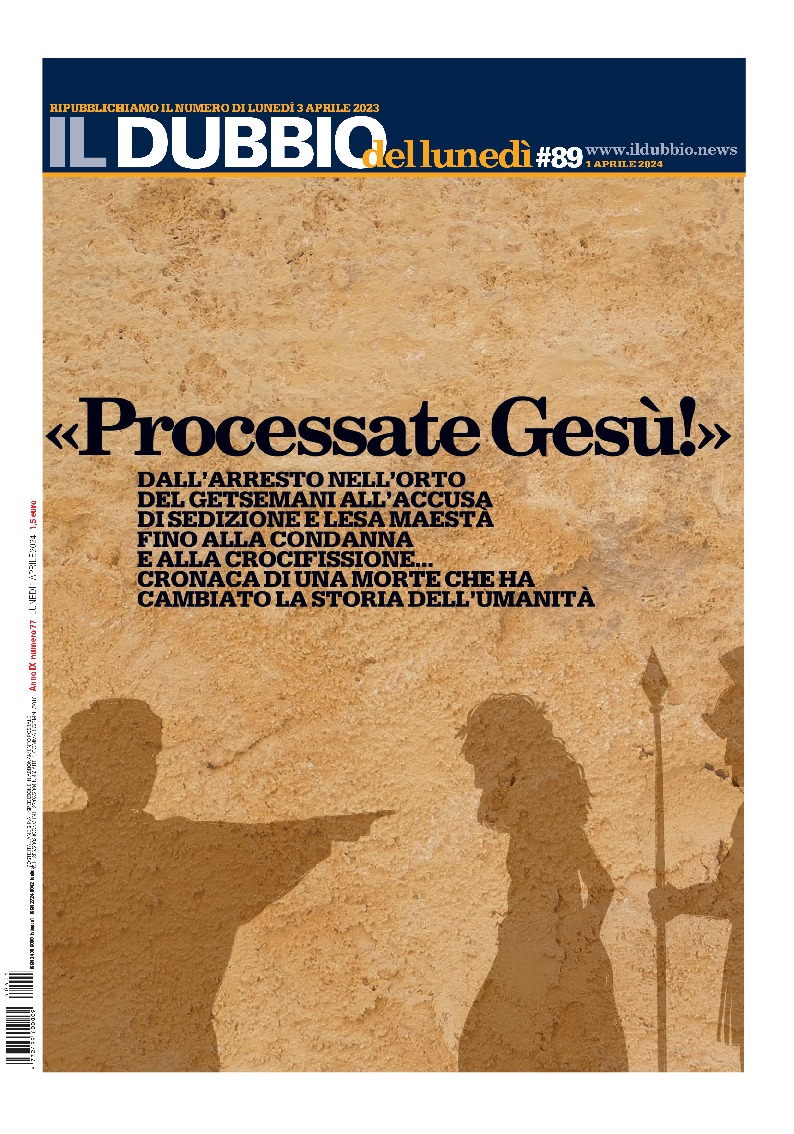PHOTO
AULA DEL TRIBUNALE PROCESSO AVVOCATO AVVOCATI CODICE PENALE
Caro Direttore,
di regola preferisco non replicare alle critiche, soprattutto quando non le ritengo condivisibili. Nel caso di Mimmo Passione, però, vorrei fare un’eccezione, non certo giustificata dalla persuasività del suo pensiero.
È infatti la seconda volta, dopo un primo “attacco” scritto a quattro mani con Mitja Gialuz, che viene superato il limite della continenza verbale. Affermare che la mia argomentazione è «un’enormità e un’indecenza che si commenta da sola», oppure accusarmi di essere un visionario stregonesco (Il Dubbio, 26 settembre 2023), sono espressioni che non tanto ledono la mia onorabilità, quanto non fanno onore a chi le ha scritte.
Il ripetersi delle reazioni scomposte di Passione denota un preoccupante massimalismo manicheo per cui la giustizia riparativa, da lui ideata insieme, tra gli altri, a Gialuz, è il bene, mentre chi osa dissentire incarna il male assoluto, da contrastare anche con le contumelie.
Da tempo sostengo che la “conca riparativa” non sia il luogo fiabesco delle emozioni, dei nudi fatti, ma molto più prosaicamente un procedimento incidentale di risoluzione alternativa della questione penale, come attestano inconfutabilmente le previsioni di legge in tema di remissione di querela, circostanze attenuanti e sospensione condizionale della pena. La giustizia riparativa è stata pervicacemente incistata nel processo penale, non solo attraverso l’improvvida previsione dell’art. 129-bis c.p.p., per cui il pm e il giudice “inviano” d’ufficio dinanzi al mediatore, in guisa di pacco postale, il reo (res più che reus), ma anche dalle svariate decine di avvertimenti disseminati in tutto il codice di rito a perenne monito per l’imputato recalcitrante (exhortationes ad poenitentiam).
Gli obiettivi dichiarati dall’art. 43 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022 sono il riconoscimento della vittima, attraverso la riparazione materiale e simbolica, la responsabilizzazione dell’imputato, che sottende la confessione e il pentimento, nonché la ricostruzione dei legami con la comunità (rectius, società) ossia il perdono stragiudiziale e collettivo subordinato a tangibili atti di contrizione.
Questo è il programma delineato dal legislatore, ben lungi dalla mistica delle emozioni, intriso di una cultura europea vittimocentrica che non si cura della questione cognitiva e della presunzione d’innocenza, ma punta solo alla rielaborazione dell’agito delinquenziale e al perdono della persona offesa. Del resto, «si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima» (art. 12, c. 1, lett. a, dir. 2012/29/UE).
Ma torniamo al tavolo del mediatore per comprendere la pericolosa commistione fra diritto e morale. Non c’è nulla di più etico che indurre un presunto innocente ad assumersi la responsabilità per un reato e, al tempo stesso, distinguere, in un preciso ruolo, chi è stato costretto a soccombere all’altrui condotta. Assunzione di responsabilità e riconoscimento delle ragioni altrui, distinguere fra bene e male, delitto e perdono, sono categorie tipiche di un giudizio morale affidato «a un saggio mediatore – psicoanalista o parroco più che giurista – come tale attento alla persona e all’anima delle parti più che alle loro contrapposte ragioni di fatto e di diritto», secondo la felice definizione di Bruno Cavallone. Rituale di espiazione che si celebra sotto lo sguardo torvo del “Tribunale del popolo”, composto addirittura dalle autorità di pubblica sicurezza, ma senza la presenza del difensore, ospite sgradito ed esplicitamente bandito.
Se il reato è (mal)inteso quale rottura di un rapporto interindividuale che deve essere ricomposto, il carattere puramente penitenziale della giustizia riparativa è rappresentato in modo icastico dalla vittima surrogata, una specie di “inginocchiatoio” messo a disposizione dell’imputato nel caso in cui la vittima del reato non esista o non voglia partecipare al percorso riparativo. Pentirsi e pacificarsi con un estraneo che significato può avere, se non quello di un atto simbolico di contrizione intriso di una esasperata visione morale del reato?
La laicità del diritto penale, tuttavia, è una conquista di civiltà alla quale non si può rinunciare senza avere ben presente che «la giustizia che insegue l’etica è espressione di uno stato autoritario», come ha affermato in una recente intervista Margherita Cassano, fonte non certo sospetta di visoni stregonesche.
I fautori del nuovo approccio non percepiscono nemmeno il rischio insito nella scelta ideologica di attribuire alla pena una diversa finalità riparativa. Corrompere il paradigma laico della rieducazione significa imporre al condannato manifestazioni di interesse e di sensibilità nei confronti della vittima o del suo surrogato, ossia un atteggiamento moralmente caratterizzato.
L’alternativa irenica al giusto processo è solo una pericolosa illusione. Come si può accettare lo scenario che vede l’imputato senza difesa dinanzi al “sano sentimento” del popolo espresso dalle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (ad esempio, donne maltrattate e simili), dagli enti locali (magari governati da chi propugna la castrazione chimica), dalle autorità di pubblica sicurezza (ovviamente ispirate da dottrine efficientiste law and order) o dai servizi sociali (art. 45 d.lgs. n. 150 del 2022)?
Il riferimento storico all’esperienza nazionalsocialista ha una sua logica pertinenza se si vuole denunciare il rischio che la versione “passionale” della giustizia riparativa contenga in sé il germe del sistema penale etico. Del resto, l’approccio emozionale e di comunità è quello che oggi invoca l’ergastolo aggravato per crudeltà.