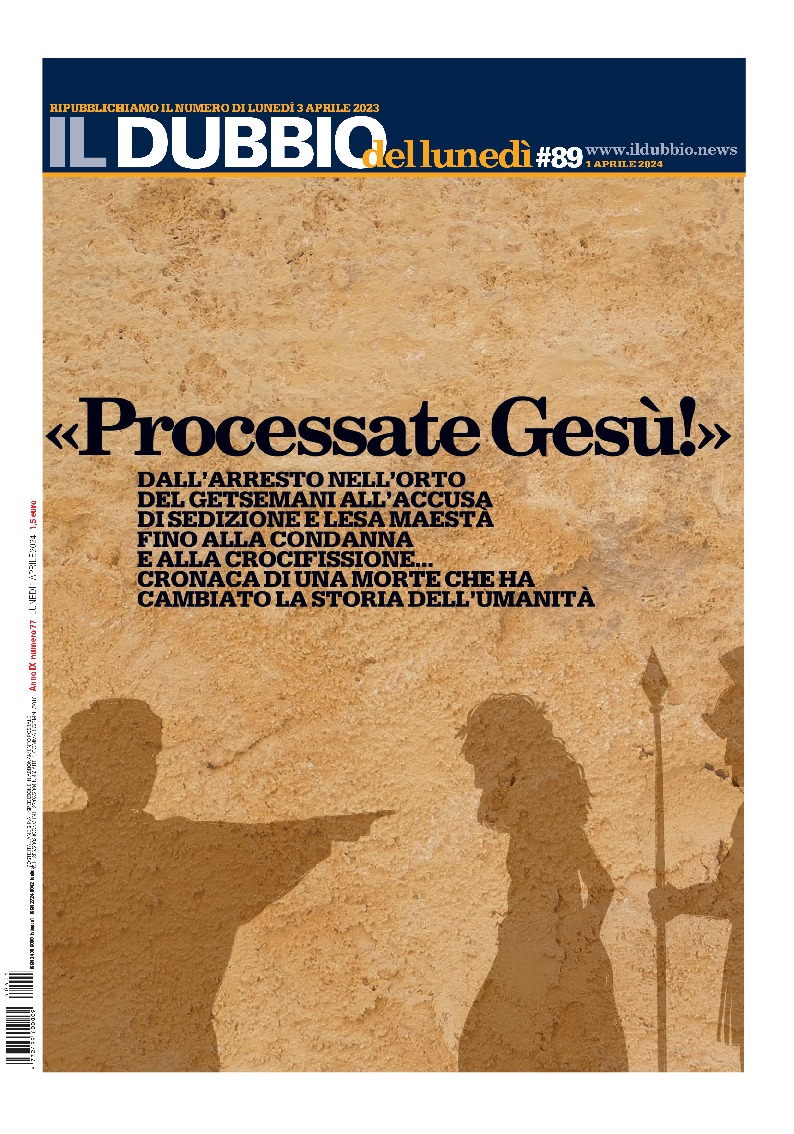PHOTO
Papa Francesco mangia con i detenuti nel carcere di Poggioreale a Napoli - 21 marzo 2015 (AP Photo/L'Osservatore Romano)
Se un’eredità brucia con forza nel pontificato di Papa Francesco appena volto al termine, è la sua crociata contro quell’indifferenza che trasforma le carceri in depositi di umanità dimenticata e il diritto penale in uno strumento di esclusione. «Ero carcerato e siete venuti a trovarmi»: il monito del Vangelo di Matteo ha trovato in Bergoglio non un semplice eco, ma un “programma di governo”. Perché Francesco non si è limitato a citare le parole di Cristo – che, nel capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, condanna senza appello chi volta le spalle ai reietti – le ha fatte vibrare nelle celle di tutto il mondo.
A soli quattro mesi dall’elezione, l’11 luglio 2013, il nuovo Papa stupiva il mondo varando una riforma penale senza precedenti. Nel cuore dello Stato più piccolo del mondo, aboliva l’ergastolo, introduceva il reato di tortura e sanciva il “giusto processo”. Un atto simbolico potentissimo: la Santa Sede diventava così un faro di civiltà giuridica, superando persino l’Italia – allora ancora priva di una legge sulla tortura e oggi, come ieri, inchiodata al dibattito sull’ergastolo.
Fin dai primi anni del pontificato, Francesco ha plasmato la sua riflessione sulla giustizia attorno a due principi che brillano come fari in una notte di derive punitive: la cautela in poenam e il primatum principii pro homine. Davanti all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, nel 2014, li enunciò con la chiarezza di chi sa che il diritto può essere strumento di redenzione o di oppressione. Il primo principio – la cautela in poenam – ribalta la logica delle legislazioni moderne: la pena non deve essere la risposta automatica ai mali sociali, bensì l’ultimo baluardo, quando ogni altra via è fallita. Una verità scomoda in un’epoca in cui il carcere diventa sempre più una “soluzione preventiva”, un luogo dove rinchiudere non solo corpi, ma speranze.
Il secondo – il primatum principii pro homine – è un monito a non dimenticare che dietro ogni reato c’è una persona, non un numero. Il diritto penale, per Francesco, deve chinarsi su quell’umanità ferita, non schiacciarla con il peso del castigo. Su queste basi, il Pontefice ha condannato senza ambiguità la pena di morte, le esecuzioni extragiudiziali («spesso mascherate da fatalità») e quelle condizioni di sovraffollamento carcerario che la Corte Europea dei Diritti Umani – in due sentenze storiche contro l’Italia (2009 e 2013) – non ha esitato a definire “trattamenti degradanti”.
Ma è nella denuncia del populismo penale che papa Francesco ha scavato più a fondo, squarciando l’ipocrisia di chi trasforma il diritto in una clava. Rivolgendosi nel 2019 all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, il Pontefice tuonò contro la deriva perversa di chi vede nella pena «l’unica medicina per ogni male sociale» – una ricetta velenosa, che sostituisce alle politiche di inclusione la comodità del castigo. «Negli ultimi decenni», spiegò con amarezza profetica, «si è creduto di curare malattie diverse con lo stesso farmaco: la repressione. Non è giustizia, è pigrizia. È la resa di chi preferisce fabbricare capri espiatori anziché costruire comunità».
Le sue parole non risparmiarono nessuno: «Non si tratta più solo di sacrificare vittime agli dei della paura, come nelle società primitive. Oggi si scolpiscono nemici di cartapesta – figure disumane, cariche di ogni minaccia – per giustificare leggi sempre più spietate». Un meccanismo, denunciò Francesco, che trasforma «il diritto penale in un’arma per dividere», e che «rinnega la sua anima: proteggere l’umano, non cancellarlo». Ha smascherato, quindi, il populismo penale: è un inganno antico, ha ricordato il Pontefice, simile a quel meccanismo stereotipato che ha favorito, nel passato, l’espansione delle ideologie razziste.
Come ricorda Nessuno tocchi Caino, papa Francesdco è «stato non solo un capo spirituale ma anche il Capo di Stato più attento allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani, soprattutto nei confronti degli ultimi, i carcerati, che in comunione con Marco Pannella ha difeso e visitato fino all’ultimo respiro in quell’opera cristiana di misericordia corporale, “visitare i carcerati”, a cui noi di Nessuno tocchi Caino laicamente e incessantemente cerchiamo di dare corpo».
Rivolgendosi ai detenuti, amava ripetere: «Nessuno può toccarvi la dignità». E quando nel 2016 lavò i piedi a 12 carcerati – tra cui una donna musulmana – quel gesto diventò un manifesto: lo Stato non deve spegnere la scintilla divina in ogni essere umano, neppure dietro le sbarre. Il 26 dicembre del 2024 ha aperto la Porta Santa del carcere di Rebibbia, nel corso del Giubileo della Speranza 2025.
L’ultimo suo atto, quattro giorni prima di morire, è stato quello di aver visitato il carcere romano di Regina Coeli. «A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere», ha detto il Pontefice durante l’incontro con i detenuti, di varie nazionalità.
Papa Francesco ci ha lasciato una sfida: trasformare il carcere da luogo di maledizione a spazio di redenzione. Non solo. In riferimento alla funzione della pena, sempre nell’audizione del 2019, ha proposto il passaggio da una giustizia basata sulla retribuzione a una giustizia basata sulla riparazione, il cui modello è l’icona evangelica del Samaritano: «senza pensare a perseguitare il colpevole perché si assuma le conseguenze del suo atto, assiste colui che è rimasto ferito gravemente sul ciglio della strada e si fa carico dei suoi bisogni». E siamo alla giustizia riparativa.